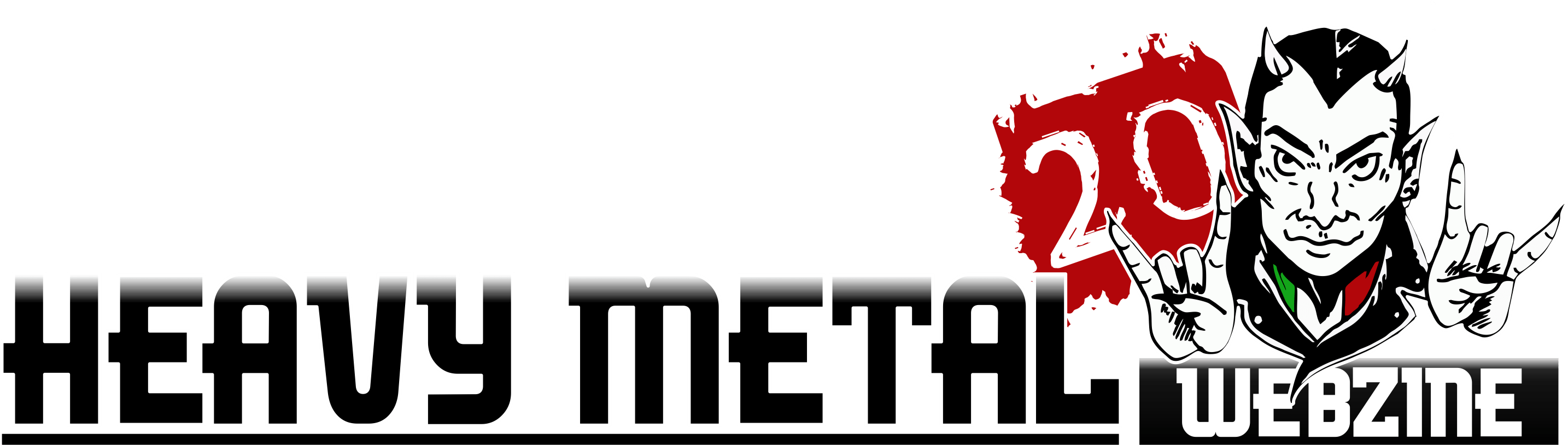Visualizzazioni post:606
C’è sempre stato qualcosa di quasi stravolgente in questo gruppo, nelle sue creazioni istintive e raffinate; lì, dentro una sorta di porta girevole che sbocca su cento giardini diversi e se ne nutre senza predilezioni né preconcetti, restituendo ogni volta un collage di dissonanze e assonanze.
Va precisato subito che rites è un lavoro praticamente unico (tanto per cambiare) nella discografia dei due: nel loro porsi pochi limiti, stavolta si sono trastullati ben più che in passato con suoni che possono attirare il gradimento del metallico pubblico, pur trattandosi quasi sempre (o sempre?) di prodotti di sintesi – d’accordo, le esecuzioni finte lì sono all’ordine del giorno ma è l’assunto ad esser diverso. Per i pando, è normale accudire il calderone da essi stessi rintuzzato di suoni ed osservarne il contenuto che si auto-rimesta, complici le correnti innescate dal bollore, in un risultato complessivo capace di trovare sempre una propria coscienza e un proprio ordine. Le esplosioni hanno luogo sull’ideale facciata A, spaziando dal noise-core al death metal; si va per gradi: è “agapē” a suggerire, “dadaism” a impazzare, “total station theodolite” a slabbrare, “the molds of men” a confermare indi demordere. Non è forse questa una delle anime della sperimentazione?
Oltre le rissose istanze, vivono campioni classici, esercizi al mix e retoriche magniloquenti: “i want to believe“, “In god we trust with our cold dead hands” [il solito giochino di una lettera più grande delle altre], la solenne “excarnation“, la pazzia di “on the shores of hell” e i turbamenti di “the octagon room“.
Per chi avverte affinità con organismi giganteschi.